 |
| La farfalla di Hofstadter |
1. Distinzione fra microstati (livello sub-simbolico) dei singoli neuroni e macrostati di pattern complessi neuronali (livello simbolico), che emergono dai primi attraverso l'auto-organizzazione ed hanno un significato in genere linguistico-simbolico completamente innovativo rispetto al livello sottostante;
2. La metafora che esemplifica la distinzione fondamentale fra i due livelli di organizzazione è quella del carambio, un ingegnoso tavolo da biliardo che vi descriverò a breve;
3. Nel nostro cervello esistono molteplici livelli di causalità che sono relativi ai diversi livelli di osservazione "micro" e "macro";
4. La nostra mente funziona secondo loop a feedback ricorsivo, la cui metafora matematica è quella della funzione iterativa ricorsiva, come ad esempio il frattale di Mandelbrot. In tale metafora, occorre immaginare la potenzialità tipica della nostra mente di porre in essere un regresso all'infinito;
5. Il loop iterativo, che da' luogo a pattern emergenti, è garantito da un fenomeno che Hofstadter chiama locking in o "ingaggio permanente" e che possiamo metaforicamente assimilare alla dinamica dei feedback audio (immaginiamo quando l'audio ha il fenomeno del "ritorno") e video (una camera che filma attraverso uno "specchio" e da' luogo ad una immagine iterativa in uno schermo Tv) ;
6. In tale quadro, quello che noi chiamiamo coscienza ed auto-coscienza è un processo complesso di tali loop iterativi fino a che emerge un loop auto-osservativo;
7. Nel modello di Hofstadter, come vedremo, rivestono notevole importanza i teoremi di Godel di incompletezza di qualsiasi sistema matematico assiomatico in quanto essi stessi sono una metafora del funzionamento della nostra mente che procede ad attribuire nuovi significati a codici apparentemente definitivi;
8. Non esiste alcun libero arbitrio, in quanto tutti i processi mentali sono rigorosamente processi fisici;
9. Quelli che in filosofia della mente sono detti qualia, al pari di quanto asserisce Daniel Dennett, sono per Hofstadter delle mere illusioni da un punto di vista scientifico, ossia non hanno una influenza oggettiva nei nostri processi coscienti.
10. Hofstadter attribuisce, invece, fondamentale importanza per la nascita dell'Io ai rapporti emotivi ed affettivi.
Una grande dote di Douglas Hofstadter, che come tutte le doti non tutti apprezzano, è quella di creare metafore ed analogie davvero incredibili ed al tempo stesso illuminanti del suo pensiero e quella del carambio come metafora del sistema cervello-mente è una di queste, diciamo la principale.
La lascio descrivere a lui:
"Immaginate un elaborato tavolo da biliardo privo di attrito con sopra miriadi di minuscole sferette chiamate 'sim' (acronimo di sferette interagenti miniaturizzate). Queste sim sbattono l'una contro l'altra e rimbalzano sulle pareti, carambolando qui e là all'impazzata nel loro mondo perfettamente piatto - ed essendo questo privo di attrito, continuano appunto a carambolare e carambolare, senza mai fermarsi. Fin qui il nostro sistema ricorda molto da vicino un gas perfetto bidimensionale, ma ora postuleremo un pò di complessità in più. Le sim sono anche magnetiche (passiamo dunque a 'simm' con la m in più per 'magnetiche') e, quando si scontrano a velocità relativamente basse, possono rimanere attaccate formando dei grossi grappoli o cluster che per brevità chiamerò 'simmbili', essendo un pò come grosse biglie fatte di simm. Un simmbilo consiste di un numero molto elevato di simm (mille, un milione, non importa) e sul suo strato esterno perde di frequente alcune simm acquistandone altre. Ci sono così due tipi estremamente diversi di oggetti residenti in questo sistema: minuscole, leggere, sfreccianti simm e giganteschi, pesanti, quasi immobili simmbili. Le dinamiche che si creano su questo tavolo da biliardo che d'ora in poi chiameremo 'carambio' coinvolgono dunque delle simm che urtano violentemente le une contro le altre e anche contro i simmbili. Senza dubbio, i dettagli della fisica comprendono trasferimenti di quantità di moto, momento angolare, energia cinetica ed energia rotazionale, proprio come in un gas standard, ma noi non ce ne occuperemo affatto, visto che questo è un esperimento solo con il pensiero (...) Perché lo scontato gioco di parole con 'simbolo'? Perché ora aggiungerò un pizzico di complessità in più al nostro sistema. Le pareti verticali che costituiscono i confini del sistema reagiscono in modo sensibile agli eventi esterni (per esempio, qualcuno che tocca l'esterno del tavolo o anche un soffio di vento) flettendosi per un attimo verso l'interno. Questa flessione, la cui natura conserva alcune tracce dell'evento causale esterno, influisce ovviamente sui movimenti delle simm che, all'interno, rimbalzano via da quel tratto di parete e indirettamente questo verrà registrato anche nei movimenti lenti dei simmbili più vicini, consentendo perciò ai simmbili di internalizzare l'evento. Possiamo presupporre che un particolare simmbilo reagisca sempre in una qualche maniera standard alla brezza, in un'altra ai colpi di vento improvvisi e così via. Senza entrare nei dettagli, possiamo anche presupporre che le configurazioni dei simmbili riflettano la storia degli eventi del mondo esterno che hanno impattato sul sistema. In breve, per qualcuno che guardasse i simmbili e sapesse come leggere la loro configurazione, i simmbili sarebbero simbolici, nel senso di codificanti eventi. Ecco il perché dello scontato gioco di parole. Senza dubbio questa immagine è improbabile e stravagante, ma tenete presente che il carambio è inteso soltanto come un'utile metafora per comprendere i nostri cervelli e il fatto è che i nostri cervelli sono anch'essi piuttosto improbabili e stravaganti, nel senso che anch'essi contengono eventi minuscoli (scariche neuronali) ed eventi più grandi (pattern di scariche neuronali) e questi ultimi hanno presumibilmente in qualche modo qualità rappresentazionali, permettendoci di registrare nonché tenere a mente cose che accadono all'esterno dei nostri crani."
Hofstadter, poi, aggiunge l'evoluzione e la sua pressione attraverso la selezione naturale come ulteriore fattore determinante della struttura dei carambi. A questo punto, direi, che la metafora del carambio-cervello è alquanto chiara ed esemplificativa con tutti i suoi elementi, ambiente esterno compreso: sorge la domanda di come interpretare il funzionamento del carambio e delle sue simm e dei suoi simmbili.
Un riduzionista tenterà di interpretare il carambio in funzione delle sole simm (i neuroni) e considererà i simmbili (i pattern) dei meri epifenomeni senza alcun valore essenziale ai fini della spiegazione del carambio, ma tale approccio anzichè semplificare la spiegazione stessa si dimostra da subito generatore di un enorme ed incontrollata complessità rispetto ad un approccio emergentista, che invece allarga lo zoom dalle simm ai simmbili (dal livello micro/sub-simbolico a quello macro/simbolico) e tenta di spiegarne il funzionamento indipendentemente dalle singole simm.
A tal proposito Hofstadter scrive che:
"D'altronde, se considerando gli eventi al livello degli epifenomeni (il livello simbolico, nda) è possibile percepirne e comprenderne una 'logica', allora noi umani non desideriamo altro che balzare a quel livello. Di fatto, non abbiamo scelta. (...) Dopotutto noi stessi epifenomeni belli e grossi e, come ho già più volte osservato, questo fatto ci condanna a parlare del mondo in termini di altri epifenomeni che si collocano più o meno al nostro livello dimensionale."
Dunque, noi esseri umani viviamo in una precisa scala fisica dimensionale e per noi non ha alcun rilievo cosa fa il singolo neurone quando parliamo, ad esempio, dell'ultimo disco del nostro gruppo rock preferito con un amico. Per noi hanno importanza le parole e la musica (e non le frequenze dei suoni).
Pertanto, come dice Hofstadter, non abbiamo alcuna scelta circa la nostra dimensione esistenziale e quindi cercare la "logica dei simmbili" è una soluzione epistemologica che appare più conforme alle nostre esigenze oltre al fatto che ci "salva" da una iper-complessità ingestibile.
Ma quale è la logica dei simmbili, ossia la logica dei pattern neuronali? Secondo il nostro tale logica è quella del feedback ricorsivo che consente l'attivazione di loop iterativi che portano fino al simmbilo per eccellenza che è il loop auto-osservativo, ossia quello che noi chiamiamo Io o coscienza.
In sostanza, per Hofstadter la coscienza è un simbolo e tra i simboli è quello al quale siamo molto probabilmente più attaccati.
Infatti, Hofstadter afferma che:
"Tra le innumerevoli migliaia di simboli che fanno parte del repertorio di un normale essere umano, ce ne sono alcuni di gran lunga più frequenti e dominanti di altri e uno di essi prende, un pò arbitrariamente, il nome di 'Io' (almeno nella nostra lingua). Quando parliamo di altre persone, lo facciamo in termini di cose quali le loro ambizioni, abitudini, avversioni, e quindi abbiamo bisogno di formulare per ognuno di loro l'analogo di un Io, che risiederà naturalmente nel loro cranio e non nel nostro. (...) Il processo di percezione del proprio sè nella sua interazione con il resto dell'universo (...) continua per tutta la vita. Ne segue che il simbolo dell'Io, come tutti i simboli del nostro cervello, parte piuttosto semplice e scarno, ma poi cresce e cresce e cresce, fino a diventare la struttura astratta più importante fra quelle che risiedono nei nostri cervelli. Ma dove esattamente? Non è localizzato in un piccolo punto: è sparso ovunque, perché deve contenere così tante cose su così tante cose."
Da questo passo, inoltre, deduciamo la funzione relazionale essenziale che ha il simbolo dell'Io, in quanto esso serve a distinguere il sé dagli altri ed a comunicare con i nostri simili. Il simbolo dell'Io, pertanto, ha una vera e propria funzione biologica di sopravvivenza e sociale di relazione.
Infine, il simbolo dell'Io (o lo strano anello emergente che noi chiamiamo Io) non è in uno specifico punto del nostro cervello, ma è distribuito al suo interno (quindi secondo Hofstadter non abbiamo alcun "elaboratore centrale" come invece asserisce Jerry Fodor e con lui i cognitivisti classici).
Ma come si risolve la causalità mentale con le simm e i simmbili del carambio?
Ne parleremo nel prossimo post.












.jpg)



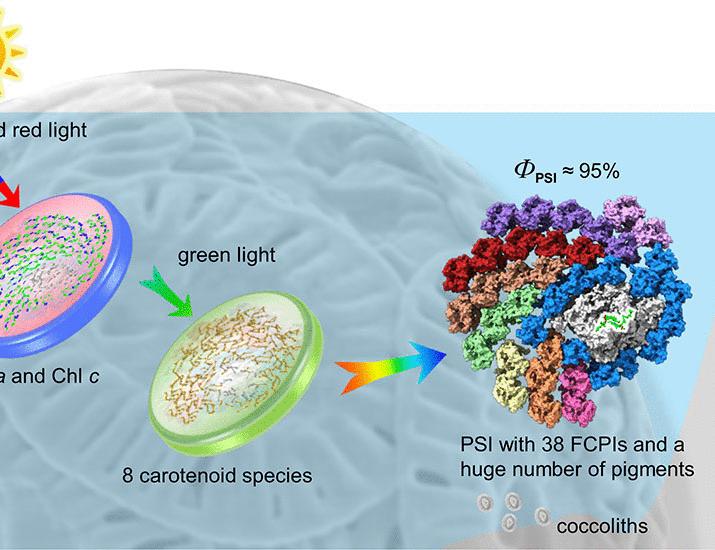

























.jpg)






