Immaginiamo quanto segue: ammettiamo che Achille dia alla tartaruga il vantaggio di 100 metri e che la tartaruga proceda ad una velocità di 1 metro al minuto mentre Achille corra ad una velocità di 300 metri al minuto (le velocità e il vantaggio sono ininfluenti, io ho scelto questi, Zenone dimezzava le distanze in successione), nel momento in cui Achille partirà e quando avrà raggiunto il punto iniziale di partenza della tartaruga quest'ultima avrà compiuto - per quanto piccolo - un tratto in avanti. Infatti, nel nostro caso dopo 1/3 di minuto Achille sarà nel punto di partenza della tartaruga, che però avrà percorso 1/3 di metro: iterando la logica del ragionamento accade che Achille non raggiungerà mai la tartaruga perché poi dovrà coprire 1/3 di metro che lo separa dalla tartaruga impiegando 1/15 secondi e quest'ultima nel frangente avrà percorso il tratto in più corrispondente alla formula spazio=velocità*tempo, che nel nostro caso sarà spazio=(1 metro/60 sec.) * (60/900 sec.)= 1/900 metro e così via all'infinito.
Più in generale, siamo di fronte ad una successione che è formata come segue: 1/3, 1/900, 1/270.000, .... ecc. (queste sono in progressione le distanze sempre più piccole che distanzieranno la tartaruga da Achille senza mai essere zero).
Questo paradosso, tale perché in contrasto con l'esperienza sensibile, ha tenuto sotto scacco il pensiero occidentale dai tempi di Zenone - formulabile in maniera discorsiva e più immediata come fece Borges nel seguente modo "Achille, simbolo di rapidità, deve raggiungere la tartaruga, simbolo di lentezza. Achille corre dieci volte più svelto della tartaruga e le concede dieci metri di vantaggio. Achille corre quei dieci metri e la tartaruga percorre un metro; Achille percorre quel metro, la tartaruga percorre un decimetro; Achille percorre quel decimetro, la tartaruga percorre un centimetro; Achille percorre quel centimetro, la tartaruga percorre un millimetro; Achille percorre quel millimetro, la tartaruga percorre un decimo di millimetro, e così via all’infinito; di modo che Achille può correre per sempre senza raggiungerla" - fino a quando non fu "inventato" (o scoperto, a seconda dei gusti) il concetto di limite nel XVII° secolo (il secolo di Leibniz e di Newton) e si dimostrò che la "serie di Zenone" è in realtà una serie geometrica convergente, che nel caso tipico "zenoniano" (che nel ragionamento originario dimezzava progressivamente le distanze), ossia la serie 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ecc., ha come limite la somma finita 2.
Fermiamoci ora a riflettere un pò su come si è passati da un ragionamento, quello di Zenone, che da un punto di vista meramente logico sembrava essere corretto (e in astratto continua ad esserlo ancora oggi), ma in contrasto con l' empiria, ad un altro ragionamento, altrettanto logico, ma stavolta basato sui concetti matematici di serie e di limite, che invece suffragava l'empiria, cioè che Achille supera sempre (ed eccome!) la tartaruga.
Zenone, come tutti i greci, non conosceva né lo zero, né gli infinitesimi, né il concetto di continuo e quindi il concetto di somma convergente ad un limite, ma insinuò - come ben dice nel suo "Tutto, e di più. Storia compatta dell'infinito" (2003) il compianto David Foster Wallace - il ragionamento del "buco nero" del regresso all'infinito all'interno della cultura greca che già aveva un certo sacro "terrore" per to àpeiron (ἄπειρος, -ον, l'illimitato, l'infinito, senza confine ecc.), tanto che Anassimandro lo considerò un "archè" (ἀρχή).
 |
| Credit: Il curioso caso di Benjamin Button (2008) |
L' Ápeiron è per Anassimandro ciò che abbracciando le cose fornisce ad esse l'essere secondo il tempo e in questo introduce due concetti importanti su cui riflettere: eterno (contrapposto al tempo finito dell'ente) e destino (legato alla necessità secondo la quale le cose tornano ad esso).
Il ragionamento di Zenone è molto insidioso perché, come dicevamo, spalanca le porte al regresso all'infinito e ne conclude che non è possibile né il movimento né lo scorrere del tempo, che pertanto sono solo delle illusioni umane.
Ci penserà Aristotele, contrapposto all'idealismo platonico, a distinguere fra un infinito attuale e un infinito potenziale, o meglio fra attualità e potenzialità, affermando che un "infinito attuale" non è possibile e che pertanto nessuna estensione spaziale è "attualmente infinita", ma lo spazio è solo "potenzialmente infinito" nel senso di potenzialmente divisibile ad infinitum.
La visione aristotelica, attraverso il cristianesimo e quindi la scolastica, sopravviverà fino alla rivoluzione del calcolo differenziale a partire dal XVII° secolo, che aprì le porte ad una trattazione dell'infinito e degli infinitesimi sempre più rigorosa e dove, soprattutto, l'infinito cominciò a imporsi come "grandezza" anche attuale, anche se si dovranno aspettare Dedekind e Cantor per avere una matematica dell'infinito vera e propria.
Tornando alla nostra riflessione iniziale, è interessante notare come sia la visione del mondo di Zenone sia quella contemporanea, basata nel caso di specie sulla matematica dell'infinito e degli infinitesimi, si basi sul pensiero astratto, che dopotutto è una forma di pensiero "metafisico" in quanto - come detto altrove dove parlavo di mente estesa - è una forma emergente di pensiero, tipicamente umano nelle sue forme più evolute e non riducibile alle mere componenti neurobiologiche in quanto legato anche agli aspetti culturali (la duplicità di aspetto di cui si parlava anche qui).
 |
| Convex and Concave (1955), Escher |
Pertanto, "scoprire" l'esistenza dei limiti e delle serie convergenti è stato fondamentale per risolvere il paradosso di Zenone, dunque per affermare con maggiore certezza che la "realtà che osserviamo è vera" e che al tempo stesso non è in contrasto con la logica e con la matematica.
Questo stato di cose è, come si intuisce, molto interessante in quanto mette in luce come il pensiero astratto di tipo rappresentativo sia stato e sia ancora nella nostra cultura fondamentale per "decifrare" il mondo, ma ci pone la domanda di fino a dove esso può descrivere la realtà fino ad "esaurirla", cioè fin dove la logica e la matematica e le loro strutture concettuali astratte siano idonee a spiegare il mondo che osserviamo senza lasciare "eccedenze" inspiegate o addirittura inspiegabili.
Nei prossimi post, attraverso una riflessione sull'infinito ci avventureremo su questi argomenti.








.jpg)





.jpg)



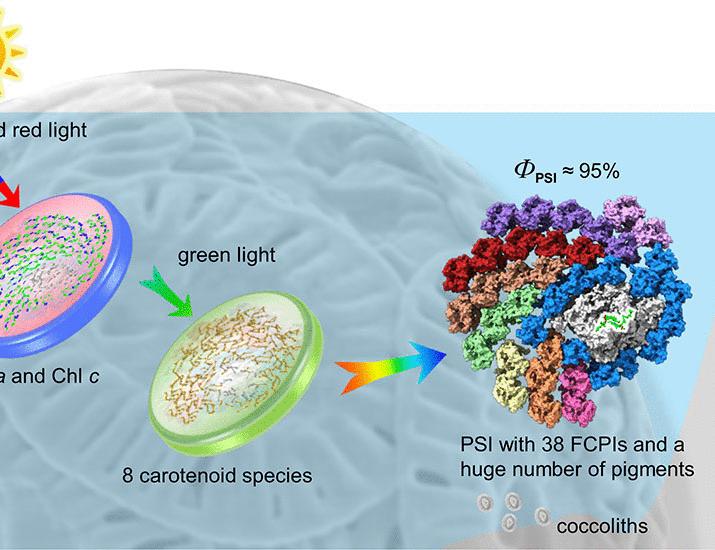

























.jpg)






