Da quell’istante sarebbe iniziato “tutto” e da quel “punto di singolarità” iniziale si sarebbe costituito ed espanso il nostro universo, che come sappiamo continua ad espandersi addirittura accelerando la sua velocità.
E’ evidente che questo modello lascia insoluti diversi problemi, che possiamo riassumere con le seguenti domande: cosa c’era “prima” del big bang? Perché c’è stato il big bang? Perché c’è stato un solo big bang? In sintesi, sono i concetti di spazio e di tempo che, intesi già solo in base al senso comune, non ci convincono fino in fondo e che ci lasciano insoddisfatti della teoria del big bang, che ad una analisi meramente formale sembra, in fondo, una genesi “quasi teologica” corretta con argomentazioni scientifiche.
Già tempo fa avevo fatto una intervista ad Ignazio Licata sul suo modello di cosmologia quantistica, elaborato insieme a Leonardo Chiatti, che è a mio parere una teoria estremamente interessante perché non solo cerca di fornire una risposta a quel “prima del big bang” e a quel “perché il big bang”, ma ci dà anche la possibilità di riflettere in maniera nuova ed originale su concetti sui quali la filosofia e la scienza stessa si dibattono da sempre e oggi con ulteriori aporie generate dalle ormai “famose” materia ed energia oscura: parliamo dei concetti di tempo, spazio, materia, energia.
In questo modello, Ignazio Licata ci stimola ad immaginare una “realtà atemporale” di forma ipersferica pentadimensionale (ci spiegherà lui perché), che è il vuoto quantistico arcaico, dal quale è emerso non solo il nostro universo, ma da cui è possibile che continuamente si generino nuovi universi all’interno di quello che possiamo chiamare con un nome, ormai noto, il multiverso.
Questo modello ha una duplice fecondità: innanzittutto e ovviamente scientifica in quanto, come vedremo, si propone di risolvere diversi problemi come quello di coniugare la teoria della relatività con la meccanica quantistica con conseguenze molto interessanti ad esempio sull’interpretazione delle citate materia ed energia oscura, ma anche – a mio parere – filosofica perché offre una prospettiva davvero innovativa su come il “divenire eracliteo” e l’“essere parmenideo” possano essere, per così dire, “intrecciati” dall’eternità.
Nel ringraziare Ignazio Licata, sempre disponibile alle mie richieste di approfondimento, vi invito a leggere e, se volete, a commentare questa interessante intervista sull’“universo arcaico”.
1. Cosa è la relatività proiettiva e perché la hai usata per il tuo modello?
La relatività proiettiva è una tecnica per studiare la relatività di De Sitter, che ingloba ed estende la relatività ristretta su scala cosmica. Suggerita dallo stesso De Sitter, e poi studiata da Kaluza e da Castelnuovo, fu indagata a fondo dal matematico italiano Luigi Fantappiè nel 1954. Viene poi ripresa negli anni '60 e '70 da teorici del calibro di Bacry e Levy-Leblond e Freeman Dyson, che la annoverava tra le grandi "missed opportunities" della fisica in un celebre articolo del 1972.
Fu Fantappiè a dimostrare che è l'unica estensione possibile del gruppo di Lorentz-Poincaré se si vogliono mantenere l'isotropia e l'omogeneità dello spazio-tempo e le 4 dimensioni.
Pensiamo che in futuro questo approccio potrà dire qualcosa anche ai vincoli cui deve sottostare una teoria multidimensionale, come è quella delle stringhe/brane, per dar luogo all'universo che osserviamo.
2. Ci puoi spiegare cosa è lo spaziotempo di De Sitter-Castelnuovo e quello di Cayley-Klein che citi nel tuo lavoro?
Lo spazio-tempo di De Sitter è un'ipersfera a 5 dimensioni (la quinta dimensione può essere considerata un artificio formale per definire le simmetrie dell'ipersfera tramite uno spazio in cui è "immersa") che ha massima simmetria, nessuna singolarità e dove spazio e tempo sono curvati ed intrecciati indissolubilmente assieme (motivo per cui il tempo è descritto da numeri immaginari ed è indistinguibile dallo spazio).
Era stato trovato come soluzione delle equazioni di Einstein con costante cosmologica e vuoto di materia e scartato perchè "poco realistico". Un osservatore fisico è un punto su un circolo massimo dell' ipersfera (che è un modo alquanto complicato di dire che sta in un volume tridimensionale dinamico!), e vede dunque tutto in rappresentazione proiettiva utilizzando le tecniche di Castelnuovo e di Cayley - Klein. Solo così può distinguere l'etichetta "tempo" dall'etichetta "spazio".
3. Perchè il vuoto ha (o dovrebbe avere) la forma di una ipersfera pentadimensionale? Che cosa è e che dimensioni ha questa ipersfera? Lo spazio ipersferico è reale? In che modo si modifica, se si modifica, lo spazio ipersferico a seguito delle nucleazioni quantistiche?
La proposta cosmologica dell' universo arcaico inizia proprio con l'assunzione che l'ipersfera di De Sitter, che è lo spazio-tempo che viene immediatamente "dopo" quello di Lorentz-Minkowki, sia anche il "tessuto quantistico" che rende lo spazio e il tempo qualcosa di più che una mera struttura di relazione!
Ricordiamo che non applichiamo la fisica quantistica all'universo perchè agli inizi "era molto piccolo", ma perchè è la trama quantistica che dà un senso fisico allo spazio, al tempo ed alla materia.
Fatta questa assunzione, abbiamo ricavato subito la condizione di Hartle-Hawking che era proposta come condizione geometrica per la funzione d'onda d'universo e che incorporava inflazione ed effetto tunnel.
Ottenevamo tutto questo con semplici considerazioni geometriche di simmetria, senza alcun riferimento alla gravità, e questo ci ha fatto capire di essere sulla buona strada per la costruzione di una cosmologia quantistica.
Per comprendere il ruolo dell'ipersfera bisogna chiarire la differenza tra fisica e matematica.
Inizierei con il ricordare che nessuno di noi ha mai visto una legge fisica, ma soltanto classi di eventi, ossia le manifestazioni che quella legge descrive.
Anche in relatività le dilatazioni dei tempi e la contrazione delle lunghezze sono effetti "prospettici" dovuti al moto relativo uniforme degli osservatori inerziali.
Ciò che conta è che il gruppo di simmetria metta d'accordo tutti gli osservatori su quali sono le leggi fisiche "buone". Matematicamente le assunzioni fatte sull'universo di De Sitter significano che le leggi vanno scritte lì, cioè che è quella la simmetria più generale possibile per gli osservatori.
Questo vuol dire che le leggi (meccanica, elettromagnetismo, gravità) vanno scritte in forma pentadimensionale, in modo da essere invarianti (cioè "buone") rispetto al gruppo di De Sitter. E proprio come avviene nella relatività ristretta, dobbiamo essere pronti a vedere "effetti relativistici" su scala cosmica e per di più descritti proiettivamente.
Curiosamente, e molto opportunamente, la fisica quantistica è quella più a suo agio dentro questa bellissima geometria. Adesso è facile (forse, solo più facile...) capire perchè l'ipersfera non si modifica mai, come le leggi, perchè è "solo" il luogo matematico dove sono scritte le leggi fisiche, che osserviamo "qui", nel nostro universo di sempre.
Proprio come in relatività ristretta, non vediamo lo spazio-tempo di Minkowski ma misuriamo dilatazioni dei tempi e contrazioni delle lunghezze. Il raggio, che fissa in modo univoco la costante cosmologica (e per essere in accordo con essa), è di circa 10 alla 28 cm.
 |
| Fonte: Scientific American |
Nel modello ci sono i parametri che descrivono le grandezze fisiche nell'ipersfera e la loro proiezione osservabile. Questo, lo ripeto perchè è un punto importante, non deve far pensare che viviamo in una sorta di grotta platonica. Questo è l'universo a tempo reale che osserviamo. Se vogliamo descriverlo attraverso leggi che siano insieme coerenti con la fisica di Einstein e quella quantistica dobbiamo scriverle sull'ipersfera, che è il "codice matematico" di ciò che osserviamo. Se restiamo nell'ipersfera abbiamo visto che spazio e tempo sono inscindibili, curvi ed intrecciati per l'eternità.
Esiste una coordinata che idealmente può percorrersi fino ad arrivare ad un cartello che dice "attenzione"! Qui finiscono i processi virtuali ed iniziano quelli “reali”.
Questo è il precursore arcaico del tempo: quando passiamo a tempo reale, quel punto è l'istante in cui avviene il big bang.
Il tempo emerge. Non è del resto l'unica teoria a spostare il tempo da un ruolo fondamentale ad uno emergente. Ricordiamo qui i loops di Rovelli, dove il tempo non ha posto in una descrizione fondamentale ed emerge solo macroscopicamente.
A questo punto la gente mostra sempre un pò di delusione e aggiunge che si aspettava di sapere "perchè" avviene il big- bang.
Sono doverose dunque alcune considerazioni. E' piuttosto sorprendente che semplici considerazioni di simmetria fissino una topologia e forniscano il terreno per un'unificazione della relatività e della teoria quantistica su scala cosmologica e che ci liberino inoltre dalle singolarità, che geometricamente sono legate all'orizzonte degli eventi degli osservatori, che a tempo reale vedono la fase di altissima coerenza iniziale "come" una singolarità. Ma c'è di più: il vuoto quantistico è in continua attività dinamica, dunque il big bang avviene "sempre" o "continuamente", come direbbero i sostenitori del multiverso.
Forse il punto di forza, e la difficoltà della teoria, è proprio l'aver introdotto una struttura logica globale atemporale, mentre noi siamo abituati a collocare ogni cosa nel tempo e con il tempo.
Ma l'universo è un evento piuttosto "singolare" ed è dunque naturale aspettarsi che per spiegare il tempo bisogna alla fine ricorrere ad un pre-tempo o un "tempo prima del tempo". In effetti, è questa una possibile formulazione del famoso teorema della singolarità di Hawking-Penrose.
Ha origine nell'equatore perchè è lì che è situato l'osservatore, l'unico punto in cui può separare spazio e tempo. Si può anche dire "all'inverso": perchè gli osservatori siano correlati dal gruppo di simmetria di De Sitter essi devono essere matematicamente pensati su un punto di circolo massimo. Ma questa è matematica. Passiamo alla fisica.
Il gruppo ci dice in modo molto chiaro che all'origine non c'è una singolarità ma uno stato non-locale di alta coerenza. Questa simmetria si rompe ed il vuoto nuclea l'universo osservato. Dal punto di vista matematico nulla cambia nell'ipersfera, dove sono scritte le leggi fisiche!
Ma a tempo reale questo accadde circa 13 miliardi di anni fa. In questo senso parliamo di cosmologia arcaica. Qui "archè" non va inteso in senso cronologico, ma logico. L' ipersfera non viene "prima" del big-bang, non c'è tempo nell'ipersfera, ma contiene le informazioni che veicolano e vincolano l'evento chiamato "big- bang".
La cosa che può stupire è che l'espansione entra a far parte degli effetti relativistici come la contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi. Essa è l'effetto combinato della curvatura del tempo e della gravità descritta non più dalle equazioni di Einstein ma dalle equazioni della relatività generale proiettiva.
Però sarebbe sbagliato pensare che è un effetto "apparente"; noi lo osserviamo davvero e questo è l'unico universo che possiamo osservare. Piuttosto è un'interpretazione che va oltre il vecchio "palloncino" termodinamico di Gamow e Lemaitre, perchè in questo caso l'espansione non è una "strana" condizione iniziale, inosservabile perchè occultata dentro una singolarità, ma piuttosto una conseguenza delle leggi fisiche nella relatività di De Sitter.
Forse una metafora corretta potrebbe essere quella del DVD: esso contiene tutte le informazioni del film, ma acquista un senso per l'osservatore quando lo si proietta (in tempo reale!). E' possibile connettere l'informazione del DVD con gli ordinari principi di conservazione materia-energia attraverso una relazione di Bekenstein (ideata inizialmente per i buchi neri). Insomma, la cosmologia arcaica è la cosmologia che descrive l'informazione del DVD cosmico.
6. Il tuo modello mi sembra di capire che consideri l'espansione del nostro universo come un fenomeno geometrico locale dovuto alle nucleazioni quantistiche dal vuoto arcaico, è corretto? Di conseguenza, non c'è una reale espansione? Come viene considerata la costante cosmologica? Come sono interpretati dal tuo modello i fenomeni conosciuti come materia ed energia oscura?
L'espansione è reale nel senso che il fenomeno che descriviamo è a tempo reale, va con i nostri orologi. Il suo significato però è da ricercarsi nella fisica definita sull'ipersfera. Entrambi sono reali: i fenomeni osservati sono di questo tipo perchè dipendono da un certo tipo di leggi e viceversa le leggi sono di un certo tipo perchè devono descrivere l'universo osservato.
Anche la costante cosmologica è "reale" e nel modello può essere considerata a fini pratici come una forza repulsiva, in realtà è un effetto geometrico proiettivo dovuto ad una cosa chiamata retrograduazione degli orologi cosmici degli osservatori.
In altre parole dipende dall'orizzonte degli eventi degli osservatori de sitteriani. Ed è la conseguenza relativistica del rapporto tra la geometria dell'ipersfera e quella sul piano proiettivo, dove noi osserviamo gli eventi.
L'energia oscura è in genere identificata con la costante cosmologica, che nel modello è essenzialmente un effetto geometrico.
La materia oscura fu ipotizzata da F. Zwicky per spiegare alcune anomalie nel moto della materia visibile attraverso della materia non luminosa. Anche qui l'universo arcaico ha qualcosa da dire, perchè compare un'accelerazione di riferimento che non può essere superata che spiega facilmente il fenomeno, ancora una volta ricorrendo alle caratteristiche generali dell'universo di De Sitter e del suo caratteristico orizzonte degli eventi.
Per semplificare, anche la "piattezza" delle sezione spaziale dell'universo osservato trova una spiegazione nella relatività proiettiva ed il modello promette previsioni accurate anche sulle anisotropie della radiazione cosmica di fondo e sulle onde gravitazionali, perchè grazie ai vincoli geometrici le equazioni della relatività generale proiettiva possono essere risolte esattamente.

7. Nel vuoto arcaico il tempo è immaginario: ci spieghi che significa da un punto di vista fisico?
I numeri complessi sono inscindibilmente legati alle caratteristiche ondulatorie, ed ho già avuto modo di ricordare come la meccanica quantistica sta a suo agio scritta sull'ipersfera di De Sitter. Di fatto, la cosmologia arcaica è una teoria dei campi invariante per il gruppo di De Sitter.
Fisicamente vuol dire che è direttamente inosservabile, come l'informazione quantistica.
8. Il vuoto arcaico continua a nucleare materia-energia e quindi a generare sempre nuovi universi? In sostanza, dal vuoto emerge un multiverso composto da infiniti universi? Ogni universo è indipendente da ogni altro o ci sono possibili "intersezioni"?
Questa ipotesi non è da escludere. Proprio come ogni vuoto quantistico ci sono continue fluttuazioni. Ad esempio quando una coppia di particella-antiparticella salta fuori dal vuoto, viene ad esistere anche nel tempo!
In modo analogo si può pensare che anche il vuoto arcaico produca continuamente nuovi universi, proprio come nella teoria dell'inflazione caotica di A. Linde, però in questo caso c'è un vincolo molto forte sul "tipo" di universi che vengono creati: sono tutti "proiezioni" di De Sitter, dunque non c'è motivo di pensare a quella che Max Tegmark chiama la classe 4 del multiverso, quella in cui ogni universo si differenzia dagli altri per valore delle costanti fisiche e forma delle leggi. La nostra è una cosmologia "economica"!
9. Nel modello il tempo reale è quantizzato (chronon), perché?
L'idea del cronone è molto antica, e attraversa quasi tutta la fisica quantistica. E' stato studiato a fondo, ad esempio, da P. Caldirola ed E. Recami. Deriva direttamente dal principio di indeterminazione di Heisenberg, ed è un "tempo minimo", ossia un intervallo di tempo al di sotto del quale una transazione quantistica non è neppure definibile, e si entra nel territorio, ancora largamente sconosciuto, della gravità quantistica.
La sua introduzione ci ha permesso alcune semplificazioni tecniche che riguardano l'applicazione della teoria quantistica dei campi definita sull'ipersfera.
 |
| Fonte: International Journal of Theoretical Physics |
10. Universi reali e vuoto arcaico coesistono da sempre e per sempre? Se ciò è corretto, ci spieghi cosa significa? Ci sono legami con l'implicate e l'esplicate order di D. Bohm?
C'è in effetti una stretta parentela tra l'olomovimento e la rotazioni di Wick da noi usate. Entrambe sono operazioni che permettono di passare da un livello di descrizione ad un altro.
Nella teoria di Bohm si tratta della struttura quantistica del mondo non-locale alle sue manifestazioni osservabili e locali. Nel nostro c'è in più un vincolo geometrico e una doppia scala dei tempi. In entrambi si passa da una descrizione sincronica ("eterna") del mondo fisico ad una diacronica, nello spazio e nel tempo osservabili.
I pregi di una teoria si vedono dal numero di cose che riesce ad unificare. L'universo arcaico è la prima teoria cosmologica ad introdurre la non-località ab initio, ed in modo piuttosto naturale, come ingrediente fondamentale del mondo fisico.
Vorrei concludere dicendo che si tratta anche di una teoria unificata pentadimensionale e dunque ci aspettiamo che pur nella sua grande economia di ipotesi, mostri una certa fecondità. Però voglio anche ricordare che il marcato delle teorie cosmologiche è quasi ampio come quello delle teorie della coscienza, e dunque mi sembra un buon correttivo alle troppe aspettative la frase di J. A. Wheeler: "Never run after a bus, a woman, or a cosmological theory. There will always be another one in a few minutes".
Questa teoria cosmologica dell’amico Ignazio Licata, come dicevo in premessa, mi offre l’opportunità di riflettere filosoficamente sui concetti classici di essere e divenire e, più in generale, sul rapporto fra metafisica e scienza.
Ne parleremo nei prossimi post.
-------------------------------------------------------
Riferimenti per la lettura:
Pubblicati su International Journal of Theoretical Physics:
http://www.springerlink.com/content/f2676tm805h34102/
http://www.springerlink.com/content/v647kwt65725812t/
Liberamente consultabili su arXiv:
Euclidean 5-sphere archaic universe, Ignazio Licata, Leonardo Chiatti
The Archaic Universe: Big Bang, Cosmological Term and the Quantum Origin of Time in Projective Cosmology, Ignazio Licata, Leonardo Chiatti





















.jpg)



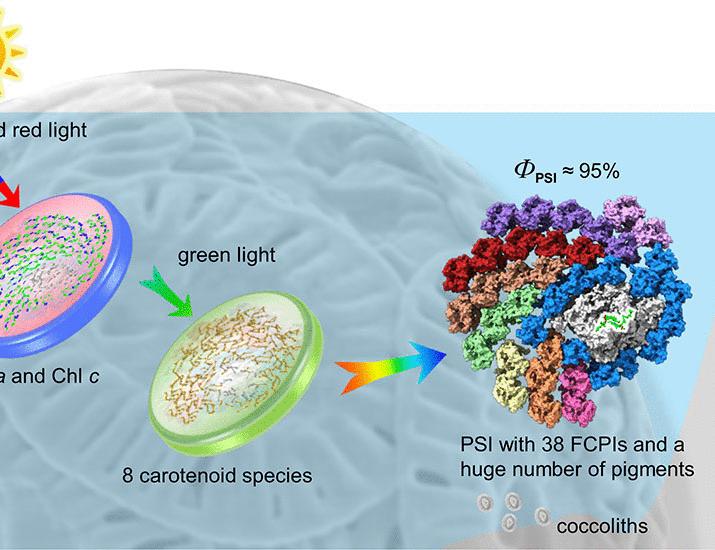

























.jpg)






