 |
| Fonte: Scientific American |
In sintesi, sia che ragioniamo in termini di "psicologia ingenua" - ossia in termini della nostra esperienza comune e delle credenze socio-culturali consolidate - sia che osserviamo le svariate indagini che si svolgono nel settore delle scienze cognitive e delle neuroscienze, le domande "Cosa causa cosa" e "Chi causa cosa" sono quelle che sorgono immediatamente, oltre ovviamente a "Come funziona" e "Come è fatto", e che ad una attenta analisi finiscono per creare non pochi problemi concettuali. Esiste, cioè, una ipotesi sottostante che tutto ciò che accade dipende da una causa, per quanto complessa essa possa essere.
L'idea di una causalità è per esempio alla base della ricerca in fisica delle particelle del meccanismo di Higgs e del relativo bosone all'LHC di Ginevra: la domanda è da dove deriva la massa delle particelle elementari e sapendo dal Modello Standard che dovrebbe "nascere" dal meccanismo di Higgs lo si cerca utilizzando le collisioni ad alte energie. Se si trova il "bosone di Higgs" allora il Modello Standard è corretto, dunque se si trova sperimentalmente la "causa" ipotizzata allora il modello descrive bene la realtà fisica (è una buona mappa del territorio). Come detto altrove, è evidente che il meccanismo di Higgs in sè è una nostra costruzione fisico-matematica e quindi non "esiste" in quanto tale, esso piuttosto appartiene alla ontologia materiale (detta anche locale) della fisica nel senso che è un "ente" specifico di questa disciplina che è sottoponibile a verifica sperimentale secondo i suoi metodi di verifica specifici.
Questo modo di procedere, dunque, caratterizza il metodo scientifico e pertanto anche quando si studia il cervello si va alla ricerca delle risposte alle domande "Come funziona" e "Chi/Cosa causa cosa", dove la seconda domanda è senz'altro intrinsecamente legata alla prima perchè per dire come funziona un qualsiasi "ente scientifico" (utilizzo un termine generico, immaginiamo ad es. la cellula o il cervello stesso nel suo insieme), sia esso un processo fisico, chimico o biologico, occorre trovare le relazioni fra quelle che si ritengono le sue parti costituenti fondamentali e fra le relative proprietà da un lato e le eventuali relazioni con "il resto del mondo" - cioè con ciò che non è definibile come quell'ente specifico di cui stiamo parlando - e tutte queste relazioni inevitabilmente hanno a che fare, in linea teorica, anche con il concetto di causa-effetto.
E' inimmaginabile pensare che se aumenta la temperatura di un corpo essa lo possa fare senza una causa - endogena o esogena che sia - o che se una persona improvvisamente impazzisce ciò non sia dovuto ad una causa che sia individuabile nella sua biografia ma anche a livello neurobiologico.
Se è vero, però, che "nonostante la nozione di causalità non sia una nozione 'tecnica', dotata di una chiara ed univoca definizione codificata nei manuali di qualche teoria formalizzata, l'analisi causale dei fenomeni sembra parte integrante del ragionamento scientifico tout court e dunque della fisica" (F. Laudisa, 2007) è altresì vero che esiste una prospettiva anticausale (cit.) in cui viene data alla nozione di legge un posto centrale dell'indagine scientifica ed in cui il concetto di causa è di fatto sostituito da quello di spiegazione, mentre la causa in senso ristretto è assimilata a quella aristotelica di causa efficiente (cosa ha prodotto cosa).
D'altronde, anche se sposiamo la tesi nomologica (legge fisica) dell'indagine scientifica è evidente che il concetto di causa ha un proprio valore pratico ed euristico ed è inoltre legato ad una nostra intrinseca dimensione cognitiva connessa alla nostra peculiare scala di osservazione e quindi non può essere totalmente escluso (sappiamo che se tocchiamo il fuoco ci bruciamo, quindi c'è un rapporto causa-effetto fra il nostro atto e le sue conseguenze). In tal senso, la causalità può essere interpretata come una relazione emergente tipica dell'agente cognitivo umano e del suo accoppiamento con l'ambiente (cit.).
In questa ultima accezione, la nozione di causalità diventa un un nostro modo di conoscere e descrivere la realtà e di farne esperienza e pertanto resta a tutti gli effetti un tipo di relazione attraverso la quale possiamo spiegare gli eventi ed i processi che osserviamo, a prescindere dal fatto se essa esista "davvero" nel mondo fisico (immaginiamo ad esempio, vista l'attualità, la reazione a catena di un reattore a fissione nucleare).
La causalità diventa in tal senso, come qualsiasi concetto scientifico, una nozione epistemologica e non ontologica (non pre-esiste cioè all'osservatore) e si può adattare ad una descrizione dei processi fisici, chimici, biologici, psicologici e socio-culturali anche se con non pochi problemi e non di rado con carenze di risultati fecondi o quanto meno univoci.
Per questo motivo, occorre utilizzare questo concetto chiarendone di volta in volta i limiti ed il significato (depotenziamento del concetto di causalità). In particolare, occorre chiarire il rapporto che c'è fra causalità, determinismo e predicibilità. L'esistenza di un processo deterministico non implica che tale processo sia predicibile come dimostrano i fenomeni di caos deterministico dei sistemi fisici dinamici non lineari che, pur essendo deterministici, sono estremamente sensibili alle condizioni iniziali e quindi non sono predicibili se non sotto specifiche condizioni/limitazioni (es. i fenomeni meteorologici) e mediante lo studio e la determinazione dei relativi attrattori.
Inoltre, come insegna la meccanica quantistica, la famosa equazione di Schrödinger è perfettamente deterministica (associa gli stati al tempo secondo una data evoluzione matematica) anche se poi è con la misurazione che si "sceglie" un suo valore di stato specifico (il cosiddetto "collasso della funzione d'onda"), che non è predicibile in partenza, ma il "mondo dei quanti" è anche descritto dal principio di indeterminazione di Heisenberg e da quello di non località - dimostrato da fenomeni come l'entanglement -, per cui in tale ambito occorre ridefinire il concetto stesso di causalità di cui un esempio può essere quello del filosofo della scienza Tim Maudlin per il quale "Una coppia di eventi A e B si implicano causalmente a vicenda quando l'evento B non si sarebbe verificato se l'evento A non si fosse verificato" (mutua implicazione causale), che presuppone una causa comune (ossia un evento) pre-esistente nel passato di A e B da cui discende ad esempio la predetta relazione di entanglement. Ne consegue che la causalità, anche nel mondo quantistico come in quello classico, non coincide con il determinismo (fra due stati s1 e s2 di un sistema quantistico c'è solo una legge deterministica e non una relazione causale del tipo che lo stato s1 causa quello s2) né tanto meno con la predicibilità, ma può comunque essere ridefinita in altri modi (cioè il mondo quantistico non è necessariamente a-casuale, come per altro la meccanica di Bohm evidenzia con le nozioni di causa formale, informazione attiva e di ordine implicito ed esplicito ) con riferimento a concetti probabilistici (come in termodinamica) come quello di rete causale ideato da Hans Reichenbach.
Una rete causale sarà, molto in sintesi, la "direzione della maggioranza dei processi" che avvengono nella rete considerata (Laudisa, cit.).
A questo punto, avendo introdotto e distinto le nozioni di determinismo (es. equazione di Schrödinger), causalità (relazione cognitiva emergente osservatore - mondo osservato, "mutua implicazione causale", "rete causale probabilistica", "ogni evento è l'effetto di qualche causa", "causalità circolare", "causalità non lineare" ecc.) e predicibilità (es. quella dei fenomeni meteorologici), possiamo farci la domanda che si è fatto Alva Noe nel suo "Perchè non siamo il nostro cervello. Una teoria radicale della coscienza", ossia da cosa deduciamo che la mente sia "causata" dal cervello, cioè che sia un processo assimilabile alla digestione per lo stomaco e che in quanto tale avvenga esclusivamente dentro il cervello e che pertanto sia solo quest'ultimo il luogo dove avvengono i fenomeni mentali.
Da quello che si legge in numerosi articoli e ricerche dei neuroscienziati sembrerebbe che la mente sia causata dai suoi stati neuronali e che quindi il cervello e la mente siano la stessa cosa: tra i due ci sarebbe totale identità e un presunto "rapporto di causalità esclusivo tra neuroni cerebrali e coscienza".
Secondo tale accezione, la coscienza è dentro il cervello e i suoi correlati sono solo (o quasi esclusivamente) quelli fisici e neurobiologici dentro il cervello.
Nel prossimo post cercheremo di vedere come Alva Noe smonti tale idea "ingenua" e come affronti il tema del confine fra il cervello, il corpo ed il mondo e proponga una teoria - se vogliamo "eretica" - di cosa sia e come si causi la mente, la nostra coscienza e, quindi, la nostra identità di esseri umani.









.jpg)



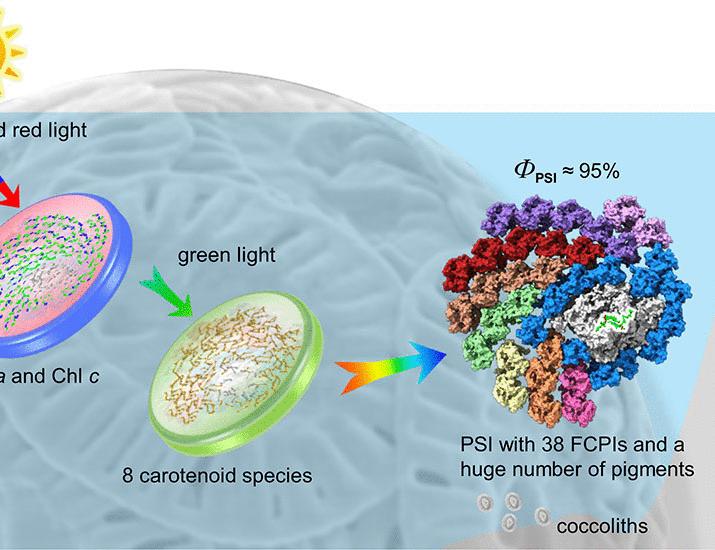

























.jpg)






